
L’epoca moderna in Italia.
Nel territorio italiano, trascorso il periodo delle Corporazioni, già al termine del 700 nascevano le prime Società Operaie, le quali favorivano lo sviluppo di coscienza di classe per l’affermazione di una “cultura della solidarietà”. Un fautore di questo movimento era Giuseppe Mazzini.
Per quanto in ritardo, la rivoluzione industriale esplodeva anche in Italia, diffondendo e consolidando la classe operaia, un proletariato emergente orientato verso ideali di trasformazione sociale, ancor più marcati dopo l’unità d’Italia, avvenuta il 4 marzo 1861. D’altro canto, il regime borghese liberale, pur mantenendo il proprio dominio di classe, ammetteva il principio sindacale nascente.
Queste società di Mutuo Soccorso, si strutturavano per esigenza in modo complesso, assomigliando da subito alle attuali Camere del Lavoro (per le gestioni locali). Dopo alcune iniziali, violente e diffuse sollevazioni contadine, nel 1864, si aveva lo sciopero dei lanieri del biellese, terminato con la stipula dell’arbitrato di Pasquale Stanislao Mancini (primo esempio di contratto collettivo).
Nel 1869, una vera e propria rivolta scuoteva il Paese, data la pretesa del Governo della riscossione dell’imposta sul macinato. In questo caso, i contadini si scontravano con lo Stato borghese, avendo compreso di non essere tutelati e considerati, nel contesto di una società capitalistica-borghese. Le prime a credere in questo associazionismo basato sul lavoro, formando le Leghe Di Resistenza di ispirazione socialista e le Leghe Bianche di ispirazione cattolica, erano le classi sociali più diseredate.
Dal 1889, veniva abrogato il divieto di coalizione e lo sciopero non era più perseguitato penalmente. Il Secondo Congresso dell’Internazionale, nel 1891, sanciva per il primo giorno di maggio la “Festa dei Lavoratori”. Di li a poco in Italia, veniva fondato il Partito dei lavoratori italiani, diventato poi Partito Socialista.
Nel 1900, veniva istituita la Federazione degli edili e nel 1901, quella dei braccianti. Il 16 settembre 1904, dopo l’ennesima strage di lavoratori scioperanti da parte dei gendarmi, si verificava uno sciopero generale senza pari sino ad allora (sia in Italia che in Europa), con una partecipazione enorme in tutto il Paese. La carenza di un’organizzazione adeguata ed efficiente portava, nel 1906, alla costituzione della Confederazione Generale del Lavoro (CGL), struttura capace di raccogliere tutte le forze operaie.
Nel 1908, giungeva il Segretariato Internazionale Cristiano e l’anno successivo il Segretariato Generale delle Unioni Professionali.
Nel 1910, prendeva forma il Comitato Nazionale d’Azione Diretta, tale ente sindacale, rivendicava il diritto di sciopero politico generale come strumento di lotta contro lo Stato borghese e contro la proprietà privata ma anche contro il Partito Socialista, tacciato di pratica riformista.
Nel 1912, alcune aree operaie (settori dei trasporti, braccianti, legno e metallurgici) che non si riconoscevano nella CGL, in quanto considerata troppo legalitaria e vicina al Partito Socialista, creavano l’USI, Unione Sindacale Italiana.
Nel 1914, con l’avvento della “grande guerra”, veniva decretata la “mobilitazione industriale” e vietati gli scioperi con conseguente diminuzione del potere contrattuale dei sindacati. Alla fine della guerra, i contadini riprendevano immediatamente le loro proteste ed il sindacato si rafforzava nuovamente.
Nel 1919, si insinuava il movimento fascista, da subito repressivo e violento nei confronti del sindacato.
Nel 1920 però, si firmava il contratto collettivo per i lavoratori del gas (primo contratto collettivo di categoria) e contemporaneamente cominciava la sua attività la Confederazione Italiana dei Sindacati Cristiani (CISC), futura Federazione Mondiale del Lavoro (F.M.L.). I fasci, nel frattempo, perseguitavano personalmente ed istituzionalmente sindacalisti ed organizzazioni sindacali e nel 1922, ne creavano una loro, ovvero la Confederazione Nazionale delle Corporazioni Sindacali. Destituivano la Festa del primo maggio ed annunciavano nel 1925, la fine delle libertà costituzionali e con questo atto la fine delle libere associazioni e del sindacato.
L’USI continuava però a vivere nella clandestinità, partecipava alla rivoluzione spagnola ed in seguito alla lotta della resistenza antifascista. Il primo marzo 1944, i lavoratori delle fabbriche italiane, ancora sotto l’occupazione nazista, scendevano in sciopero e nella notte fra il 3 ed il 4 giugno dello stesso anno, durante la liberazione, Giuseppe di Vittorio, Achille Grandi ed Emilio Canevari, sancivano la “dichiarazione sulla realizzazione dell’unità sindacale” (Patto di Roma), così si restituiva al Paese un sindacato unitario: la Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL), un grande sindacato, presente ed attivo in tutto lo Stivale.
Riconquistata la libertà e la democrazia, a breve si sviluppavano sindacati con culture diverse, differenti opinioni sulla politica sociale e sul concetto di sindacato e di rappresentatività. Dopo l’attentato a Togliatti e lo sciopero prolungato, proclamato da CGIL nel 1948, avveniva la prima rottura dell’unità sindacale, accusata (la CGIL) da alcuni di essere troppo politicizzata, veniva così alla luce la Libera Confederazione Generale Italiana del Lavoro (LCGIL).
Nel 1949, anche i repubblicani uscivano dalla CGIL ed aggregati alla LCGIL davano vita alla Confederazione Italiana Sindacato Lavoratori (CISL), di stampo cristiano. Successivamente sorgeva l’Unione Italiana del Lavoro (UIL), formata da socialdemocratici e repubblicani.
Altre organizzazioni sindacali di minore importanza per numero di iscritti, storia e
strutturazione, facevano man mano la loro comparsa: la Confederazione Italiana Dirigenti d’Azienda (CIDA); la Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori (CISAL), composta da lavoratori parastatali, enti locali e bancari, tradizionalmente forte nella scuola; la Confederazione Unitaria di Base (CUB), dal 1992 raccoglie lavoratori insoddisfatti del nuovo corso politico ed usciti dalle maggiori Confederazioni; altri sindacati di base quali Cobas, USB (Unione Sindacale di Base), A.S. La COBAS, l’USI (Unione Sindacale Italiana) ecc; erede della CISNAL l’Unione Generale del Lavoro (UGL), politicamente ispirata alle posizioni della destra sociale; i sindacati di Polizia, dopo la smilitarizzazione del Corpo del 1981, tra i principali Siulp e Sap (autonomi) ecc.
Negli anni ’60, l’azione sindacale risultava intensa, anche la classe operaia viveva un periodo di importante coscienza sociale, impegnandosi decisamente nelle battaglie per la conquista dei giusti diritti, ottenendo numerosi successi. Apparivano parecchi movimenti giovanili e non, quali Potere operaio, Avanguardia operaia, Lotta continua ecc e le organizzazioni sindacali tradizionali riuscivano a controllarli in qualche modo ed a trarne beneficio, raggiungendo una serie di obiettivi salariali ed organizzativi, sanciti nei nuovi contratti.
Nel 1970, veniva discusso ed approvato a livello parlamentare lo “Statuto dei lavoratori” (legge 300/1970), comprendente fra gli altri il tanto discusso articolo 18 (reintegrazione del posto di lavoro).
Nel 1971, le lavoratrici ottenevano una serie di garanzie sia a livello contrattuale che legislativo, dalla parità salariale alla conservazione del posto di lavoro nei periodi pre e post maternità.
Nel 1972, CGIL, CISL e UIL concretizzavano la Federazione unitaria (triplice alleanza) e nel 1975, aderivano alla Confederazione Europea dei Sindacati (CES, fondata nel 1973).
Da questo momento in avanti, il sindacato aveva modo di incontrarsi, confrontarsi e scontrarsi con la realtà politica, economica e sociale italiana. Con l’avvento di nuove intricate vicende politiche ed economiche, del deficit e dell’inflazione, dei licenziamenti e della cassa integrazione, della scala mobile e della riforma del salario e del sistema contrattuale, le relazioni sindacali vivevano una fase critica e molto impegnativa.
Nel 1995, venivano modificate le condizioni per la costituzione delle RSA (Rappresentanza Sindacale Aziendale, elette dalle singole confederazioni) e introdotte le RSU (Rappresentanza Sindacale Unitaria, elette dai lavoratori, indipendentemente dalla sigla sindacale di appartenenza e dei candidati e degli elettori), le quali andavano a sostituire quasi totalmente le RSA, per garantire omogeneità nell’azione sindacale ed evitare contrasti tra le varie componenti sindacali.
Nel 2000, dieci milioni di italiani, rispondevano NO al referendum che chiedeva l’abrogazione dell’articolo 18.
Nel 2001, saliva al potere il secondo Governo Berlusconi, altamente destabilizzante, tanto che metteva a dura prova la tenuta dell’alleanza sindacale. Infatti, la concertazione veniva accantonata e subentrava il cosiddetto “dialogo sociale” che presupponeva, la consultazione delle parti sociali ma non necessariamente un’intesa con loro.
Nel 2002, la difesa dell’articolo 18 diventava una priorità assoluta, tanto che il 16 aprile, CGIL, CISL e UIL proclamavano uno sciopero generale contro le deleghe sullo stesso e contro la proposta di decontribuzione previdenziale.
Nel 2003, in merito alla sospensione triennale per alcune particolari categorie dell’articolo 18, veniva firmato un accordo separato, con il favore di CISL e UIL e la radicale opposizione della CGIL, una nuova gravissima rottura.
Nell’attuale situazione di profonda e preoccupante crisi generale del Paese, dell’Europa e di buona parte del Pianeta, con i tremendi e raccapriccianti provvedimenti attuati dai vari Governi, a discapito delle masse proletarie, il sindacato dovrebbe essere presente, convinto ed arrabbiato come non mai, lottare aspramente prendendosi anche inevitabili rischi, dovrebbe poi prepararsi per un nuovo futuro ma non senza attingere alla forza che ebbe in alcuni periodi particolari del passato. La storia sindacale dei giorni nostri è cosa nota e comunque merita un articolo dedicato di relazione ed approfondimento.
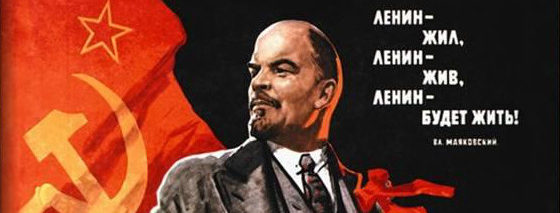
Lascia un commento